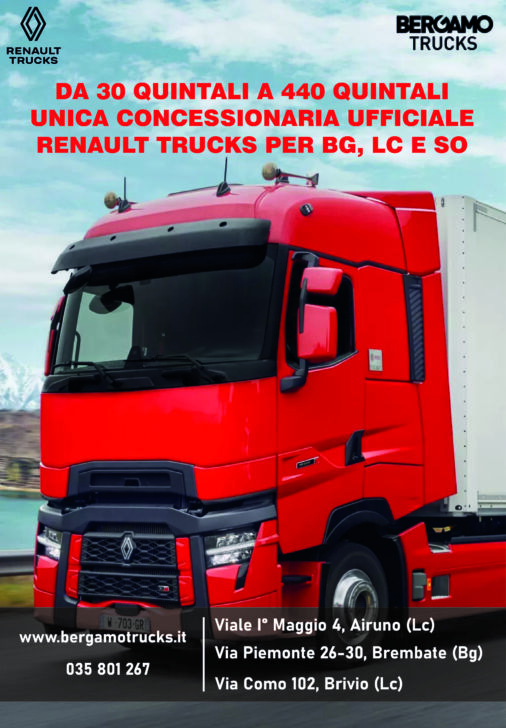di Simone Fornoni
Tutti gli addetti ai lavori, in qualunque ambito, quando le cose vanno a remengo o sembrano andare in quella direzione, si fanno prendere dalla nevrosi di turno. E sbroccano, tra parole da chiodi e brontolii di disapprovazione, di pessimismo cosmico sul presente, che è sempre un fatto contingente, e figuriamoci sul futuro. L’Atalanta ne sta calamitando fin troppi, di isterismi del genere più svariato. Non soltanto perché l’artefice primo del suo miracolo, Gian Piero Gasperini, non avendo mai annoverato nel vocabolario personale i concetti stessi di ipocrisia e diplomazia, ormai sta andando a ruota libera in qualunque risposta, nella certezza di non dovere alcunché a chiunque gli porga domande, scomode o innocue che siano. Forse anche perché non gliene frega niente di ammanicarsi i mass media e quindi di lasciare brutti ricordi, perché stima e riconoscenza sono una cosa mentre il calcio, come dice lui, va avanti. Ma anche perché la squadra, come il pubblico, in rapporto empatico e anzi simpatetico, stanno con ogni evidenza soffrendo il momentaccio, tre scivoloni di fila senza nemmeno il sorcetto di un pallone nella porta nemica, figlio della caduta del sogno dell’impossibile, parafrasando il mister stesso.
I tifosi, basta leggerne i commenti a mezzo social network, rimangono spaccati su ogni minimo cenno di allenatore e campioni stanchi. Scioccati a ogni piè sospinto, sbalorditi come di fronte a un mito alle soglie del tracollo. Scioccati e inebetiti dai fatti del campo, ma anche e soprattutto dalle parole dei protagonisti e non, quelle parlate a voce che secondo un antico adagio dovrebbero invece volare e quelle scritte che forse rilette più in dettaglio potrebbero avere un peso specifico inferiore alle pietre. Non ci stanno più dentro, o così pare a giudicare dall’autoscontro Hien-Kolasinac col primo scavalcato dal rilancio del portiere degli altri e pure dallo spondista laziale Dele-Bashiru per il matchball di Isaksen, nemmeno quelli pagati per rendere a pelo d’erba vestendosi addosso, oltre il nerazzurro, i colori di tutto un popolo abituato a spaccarsi la schiena per raggiungere l’obiettivo. Professionalmente e nella vita di tutti i giorni, familiare e sociale, a casa e nella pòlis chiamata Bergamo, comunità di pettegole da ballatoio però capace di sentimenti puliti e sinceri, nonché di disperarsi per una qualificazione alla Champions League che, insomma, ormai è un atto dovuto non essendoci rimasto altro e in fin dei conti i è solcc.
Bubbole, retropensieri sul rinnovo gasperiniano inclusi. Considerazioni che al massimo avrebbero la facoltà di fare la proprietà e la gestione sportiva. I Pagliuca e i Percassi. Non il metalmeccanico che nel weekend può ancora concedersi il diritto, o forse sarebbe meglio definirlo lusso, di perdere la voce e spesso la pazienza per seguire quella che per lui è molto di più della squadra del cuore. La Dea è il cuore e basta, per tantissima gente. Gente che sta in depressione, se non addirittura incazzata come iene. Senza il portafoglio e i tacchetti di quanti, involontariamente si capisce, ne stanno provocando i sentimenti assai poco costruttivi di cui sopra. Com’è che un popolo così pragmatico, così legato ai fatti e ai risultati, come i bergamaschi, si sta facendo abbattere dall’alto di un terzo posto che al massimo dopo Bologna-Napoli può retrocedere a quarto senza perdere di vista l’ultimo obiettivo stagionale?
Semplice. Perché quei nerazzurri che corrono indietro al pallone ne sublimano la volontà di riuscire nella vita, rappresentandone il riscatto quando il popolo dei tifosi, uomini, donne, figli, madri e padri, non ce la fa. Perché, in un mondo attraversato da nembi sulfurei di guerra, lo sport è guerra in tempo di pace e consola le anime perse. Ma se sei l’Atalanta che nei primi anni ottanta navigava sottocosta nell’inferno della serie C, potrà mai alimentare nevrosi l’essersi visti sfuggire via lo scudetto con l’Inter a tiro della sospensione per imbarellare il tifoso interista fuori dagli stracci perché non regge l’alcool? O dare la colpa di una flessione tutt’altro che irrimediabile il Gasp solo per aver detto alla vigilia di Empoli che probabilmente non ci sarebbe stato, a sua sensazione, alcun prolungamento del contratto?
La risposta è scontata. No, che non lo può. Eppure sta succedendo. Parte del pubblico è spazientita, un’altra ci perde il sonno. Il tifo è emotivo, quindi irrazionale. Logico che i più istintivi esplodano e somatizzino. Concedete, comunque, di farvelo dire da uno che dell’Atalanta non è mai stato tifoso, lo scrivente, anche a costo di rischiare di erodere la vostra sopportazione un altro po’. Gli unici fallimenti, nella vita, sono delle società a scopo di lucro che non riescono più a far fronte ai creditori. Non esistono nella vita personale, né nel calcio. Se non sarà Champions, con o senza il Vate in panchina, e non saranno nemmeno più le altre ribalte europee, nessun dramma. Nessuna nevrosi. Uno spreco di tempo, di energie, di salute. L’identificazione con qualunque espressione della vita civile non vale nemmeno un grammo d’inappetenza.
La responsabilità, infatti, al pari del potere di cambiare le cose, è e sarà sempre a carico di vostri eroi che corrono su quel rettangolo magico, dove la sfera non rimbalza a comando a loro favore, di metri centocinque per sessantotto. Perché il pubblico è il dodicesimo uomo soltanto per modo di dire. Hai voglia a trascinare alla vittoria chi non ha più niente da dire e da dare, mica in eterno, per carità, solo in un periodaccio. Non siete mica voi i ricchi salariati col dovere di prendere a calci l’arnese di cuoio perché vada nel verso giusto. E quanto alla chiusura del ciclo, leggetevi il commento al riguardo di Alessandro Lissa Pezzotta, l’omone della Tribulina che coordina i bordocampisti di servizio al Gewiss Stadium…


 lunedì 7 Aprile 2025
lunedì 7 Aprile 2025